|
|
|
|
|
SCHEDA DIDATTICA 1 |
|
LA CERAMICA
GRECA |
|
ANFORA PANATENAICA
È il nome di un particolare tipo di anfora riservata ai
vincitori delle gare atletiche durante le 'Grandi Panatenee', le
feste che si celebravano ad Atene in onore della dea Athena ogni
quattro anni. In origine erano nate come festa cittadina, ma col
tempo erano diventate 'panelleniche', perché vi partecipavano
atleti provenienti da tutto il mondo greco.
Le gare sportive di queste feste erano le stesse dei giochi
olimpici, e duravano tre giorni; i vincitori ricevevano in
premio delle anfore piene d'olio (ricavato dagli ulivi sacri
alla dea) e un'anfora dipinta. Su quest'anfora, detta
panatenaica, da un lato era rappresentata Athena guerriera (Promachos),
con l'iscrizione ton Athenethen Athlon, cioè 'dalle gare
ateniesi', sull'altro era dipinta la disciplina nella quale
l'atleta era risultato vincitore.
Inoltre gli atleti vincitori nei vari Giochi dell'antica
Grecia (Olimpia, Delfi, Nemea, Istmia) avevano la possibilità di
farsi erigere, ma a proprie spese, una statua celebrativa,
intesa sia come dono
alla divinità che li aveva protetti portandoli alla vittoria sia
come testimonianza destinata a trasmettere nei secoli il ricordo
del trionfo nella gara. E ad essere celebrati con un
componimento poetico (anche questo molto costoso). |

 |
|
Anfora panatenaica a
figure nere attr. al Pittore di Kleophrades,
ca. 525–500
a.C.
(New York,
Metropolitan Museum of Art) |
TECNICA A FIGURE NERE
È una tecnica della
ceramica greca, sviluppatasi in Attica dal
VI secolo a.C. È
chiamata così perché le raffigurazioni sono di colore
prevalentemente nero su uno sfondo uniforme rosso (di varia
intensità).
Il procedimento era
lungo, ma alla fine si otteneva una pittura dai
colori brillanti, praticamente indelebili nel
tempo. Questi vasi, alcuni dei quali erano dei
veri capolavori, spesso venivano firmati sia dal
ceramografo (il cui nome era preceduto dal verbo
epoiesen,
'fece') che dal pittore (egrapsen,
'dipinse').
Le fasi di
lavorazione erano le seguenti.
1. Il vaso veniva modellato con l'argilla. Una volta che si
era essiccato, la superficie veniva levigata usando delle
pietre abrasive. Quindi veniva immerso in un bagno di colore
ocra, per rendere uniforme e più intenso il colore
dell'argilla.
2. Su questa superficie uniforme si incidevano i contorni
delle figure, entro i quali con un pennellino si stendeva
una miscela ottenuta mescolando argilla liquida con sostanze
ferrose e carbonato di sodio (la futura 'vernice nera'). I particolari si ottenevano incidendo le figure
dipinte con linee sottilissime che scoprivano il fondo rosso
naturale del vaso. Si potevano anche aggiungere tocchi di
rosso (ocra) e/o di bianco (argilla depurata) per rendere
più comprensibili alcune parti anatomiche.
3. Si passava poi alla cottura, una fase
importantissima del procedimento perché
era nel forno che le |
|

Exekias,
Achille gioca a dadi con Aiace,
ca 540 a.C. (Antikensammlung Berlin) |
|
sostanze ferrose
diventavano nere mentre il carbonato dava
brillantezza alle parti dipinte. Per ottenere questi
risultati la cottura era effettuata in tre fasi,
continue, con temperature tra gli 800° e i 1000°
gradi.
Nella prima fase l'argilla assumeva un colore rosso
brillante, sia nello sfondo che nei dettagli delle
figure. Nella seconda fase si immettevano sostanze
fumogene nel forno cosicché le parti dipinte
diventavano nere, a causa della reazione chimica
delle sostanze ferrose. Nella terza fase si
immetteva aria (ossigenazione): le parti dipinte in
rosso tornavano rosse, quelle in nero rimanevano
tali e diventavano lucenti, quelle in bianco
restavano inalterate.
La tecnica a figure nere è essenzialmente
grafica.
Le figure sono sintetiche e bidimensionali, dando un
effetto silhouette.
(Disegno da Focus -
Storia. La Grecia antica,
n.5, inverno 2005) |
|
 |
TECNICA A FIGURE ROSSE

Sosias,
Coppa con Achille che medica Patroclo,
ca 500 a.C. (Antikensammlung Berlin, F2278) |
Questa tecnica
si sviluppa a partire dal
530 a.C. circa, come una
evoluzione di quella a figure nere, che finirà per
essere soppiantata. Con quest'ultima il procedimento
di produzione presenta molte affinità, ma anche
significative differenze.
1.
La fase iniziale (modellazione,
preparazione della superficie, bagno di ocra) era analoga a quella usata nella tecnica a
figure nere.
2.
Come nella tecnica precedente, sulla superficie uniforme si incidevano i contorni
delle figure. Ma la miscela colorata che dava la 'vernice nera'
si stendeva non entro i contorni delle figure ma al
di fuori di essi, coprendo la superficie del vaso.
Rispetto alla tecnica precedente, le silhouettes
venivano perciò realizzate "in negativo" o “a
risparmio”, facendole emergere dallo sfondo
nero: il rosso delle figure è quindi quello
dell'argilla grezza.
Invece di essere incisi, i dettagli delle figure
erano dipinti sul fondo attraverso linee di
differente spessore, creando così maggiori
particolari (negli atteggiamenti, direzione ed
espressione dei volti, movimento dei panneggi) e
dando un effetto tridimensionale alle figure.
Insomma, si ottenevano risultati di maggiore naturalismo.
3.
La cottura procedeva in modo analogo, ma
con alcune modifiche, ad esempio eliminando le
sostanze fumogene e ossigenando in modo diverso il
forno. |
|
CURIOSITÀ:
COPIE E DERIVATI DI EPOCA NEOCLASSICA
|
|
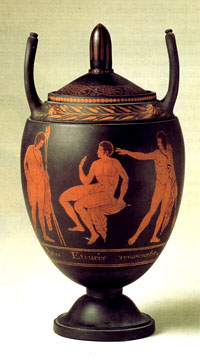 |

Dejeuner con scene etrusche,
ceramica dipinta
e dorata, 1803-06, Real Fabbrica di Capodimonte |

Servizio di ceramica dipinta 'a figure nere',
Imperiale e Reale fabbrica di porcellana di Vienna |
|
Vaso First Day, basalto nero con decorazioni
a encausto,
1769, Produzione Josiah Wedgwood |
|
|
|
(Giulia Grassi,
marzo 2009) |
|
|
|
|
|
|
|